Con l’intervista a Stefano Epifani – Presidente Fondazione per la Sostenibilità Digitale e Docente di Sostenibilità Digitale all’Università di Pavia – l’editoriale di questo numero di inGRUPPO ci aiuta a riflettere e ci guida a comprendere come e perché la digitalizzazione e l’efficienza tecnologica siano condizioni necessarie allo sviluppo sostenibile di un’azienda. Una sfida prima di tutto culturale: digitalizzare non solo “per fare di più” ma “per fare meglio”. La Sostenibilità Digitale può diventare, infatti, un motore di cambiamento del sistema produttivo italiano.
La Fondazione per la Sostenibilità Digitale che lei presiede sostiene che le tecnologie digitali hanno un ruolo primario per lo sviluppo di un futuro sostenibile. Ci può aiutare a comprendere come queste tecnologie possano ridurre gli impatti negativi che le imprese manifatturiere hanno su ambiente, clima, aspetti sociali ed economici, e contribuire a enfatizzare gli impatti positivi?
La sostenibilità – come spesso accade quando si parla di trasformazioni complesse – non è solo una meta, ma un percorso. E in questo percorso, le tecnologie digitali non rappresentano un semplice strumento, ma un vero e proprio fattore abilitante. Abilitante di cosa? Di un ripensamento radicale dei modelli produttivi, dei comportamenti organizzativi, delle logiche decisionali. In una parola: del senso stesso dello sviluppo industriale.
È per questo che, come Fondazione per la Sostenibilità Digitale, riteniamo fondamentale sottolineare il ruolo del digitale non come fine, ma come mezzo. Un mezzo che, se orientato consapevolmente, può trasformare il sistema manifatturiero da fattore di impatto a leva di rigenerazione.
Pensiamo, ad esempio, all’ambiente: parlare di digitalizzazione in questo ambito significa immaginare imprese capaci di monitorare, prevedere e correggere in tempo reale i propri consumi energetici, grazie a ecosistemi IoT integrati con piattaforme di analisi predittiva. Ma anche di intervenire prima che i guasti diventino disastri, che gli sprechi diventino sistema, che l’inefficienza diventi norma.
E sul versante climatico? La vera innovazione non è (solo) tecnologica, ma di trasparenza. Tracciabilità digitale delle filiere, analisi del ciclo di vita dei prodotti, gestione dei dati ambientali in logica open: sono questi gli strumenti per un’industria che non subisce la transizione ecologica, ma la guida.
Poi c’è l’impatto sociale. E qui il digitale mostra, più che altrove, la sua ambivalenza. Può escludere, ma può anche includere. Può automatizzare, ma anche umanizzare. Dipende, ancora una volta, dalle scelte. Favorire l’inclusione lavorativa, migliorare le condizioni nei contesti usuranti, valorizzare le competenze attraverso la formazione digitale: sono obiettivi raggiungibili, se non ci si limita a “mettere tecnologia”, ma si costruiscono contesti. E soprattutto, se si tiene conto delle PMI, troppo spesso escluse dalle grandi narrazioni sull’innovazione, eppure centrali nel tessuto manifatturiero europeo.
Ma attenzione: digitalizzare non basta. Così come non basta “essere sostenibili”. È nella convergenza fra le due transizioni – digitale e ambientale – che si gioca la partita. E questa convergenza non è tecnica, è culturale. Non è un aggiornamento di sistema, ma un cambio di paradigma. Per questo parliamo di sostenibilità digitale. Perché serve una cultura capace di leggere l’impatto sistemico delle tecnologie e orientarne l’uso verso il bene comune. Solo così – davvero – il digitale potrà diventare il motore di un’industria sostenibile.
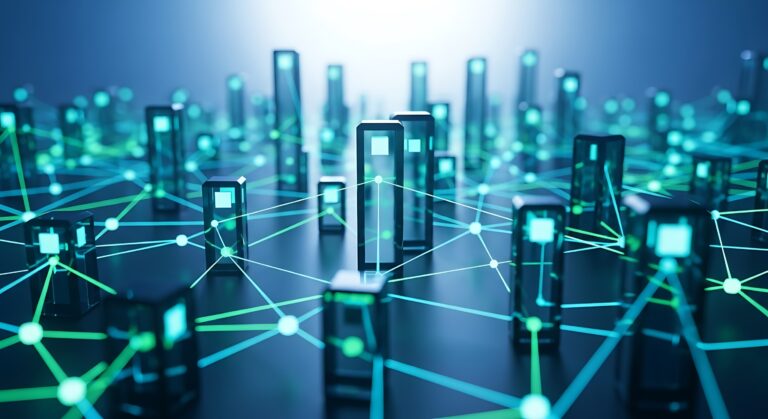
A suo avviso qual è il livello di consapevolezza delle imprese manifatturiere, in particolare delle PMI, sul ruolo della digitalizzazione per facilitare la riduzione degli impatti negativi su ambiente, clima e persone? E il livello applicativo? Come può essere ulteriormente migliorato?
Quando si parla di trasformazione digitale e sostenibilità, il rischio più grande non è la lentezza del cambiamento, ma la sua frammentazione. In altri termini: non è tanto il “non fare” a preoccupare, quanto il “fare a pezzi”, perdendo di vista la visione d’insieme. E questo è esattamente ciò che accade, oggi, in larga parte del sistema manifatturiero italiano, soprattutto tra le PMI.
Secondo i dati che raccogliamo attraverso il nostro Osservatorio per la Sostenibilità Digitale, il livello di consapevolezza delle imprese rispetto al potenziale del digitale per la riduzione degli impatti ambientali, climatici e sociali è ancora, per usare un eufemismo, disomogeneo. C’è chi inizia a intuire le connessioni, chi si limita a riconoscere la necessità di innovare per essere competitivi, e chi, purtroppo, continua a vivere sostenibilità e digitalizzazione come due percorsi paralleli, se non addirittura alternativi.
Il punto è che, nella maggior parte dei casi, manca una visione integrata. Si digitalizza per produrre meglio, per automatizzare, per ottimizzare i costi. Ma raramente ci si chiede: “e tutto questo, che impatto ha sul mio territorio? Sui miei lavoratori? Sull’ambiente in cui opero?” È questo il nodo da sciogliere: far comprendere che l’efficienza tecnologica non è un fine, ma una condizione necessaria – e non sufficiente – per uno sviluppo sostenibile.
Lo conferma il nostro indice DiSI, il Digital Sustainability Index: solo una minoranza delle PMI adotta un approccio davvero maturo, in cui il digitale viene impiegato non solo per “fare meglio”, ma per “fare il bene”. Per monitorare le emissioni, ottimizzare i consumi, garantire sicurezza, tracciare la filiera. In troppi casi, ciò che manca non sono le tecnologie – che pure esistono, e sono accessibili – ma la capacità culturale di immaginarne un utilizzo strategico orientato alla sostenibilità.
Dunque, che fare? Serve un cambio di paradigma, certamente, ma anche una strategia operativa che si articoli lungo alcune direttrici fondamentali:
- Formazione mirata: non si tratta solo di aggiornare le competenze tecniche, ma di costruire una nuova alfabetizzazione, capace di connettere il sapere tecnologico con la visione sistemica della sostenibilità. Senza questa connessione, ogni innovazione resta sterile.
- Incentivi integrati: le politiche pubbliche devono evolvere. Non basta premiare chi innova; occorre sostenere chi innova bene, chi orienta l’innovazione verso obiettivi sociali e ambientali condivisi.
- Ecosistemi territoriali d’innovazione: la PMI non può – e non deve – essere lasciata sola. È necessario creare contesti in cui imprese, enti locali, università e centri di ricerca collaborino per condividere esperienze, soluzioni e prospettive.
- Misurazione dell’impatto: come si può migliorare ciò che non si misura? Le imprese devono essere accompagnate verso un approccio basato su indicatori concreti, che rendano visibili – e valutabili – i benefici del digitale in termini di sostenibilità.
La vera sfida non è solo tecnica, ma culturale. Non dobbiamo semplicemente “digitalizzare per fare di più”. Dobbiamo “digitalizzare per fare meglio”. E meglio, in un mondo segnato da crisi ambientali e diseguaglianze sociali, significa generare valore condiviso, agendo in modo responsabile sui contesti nei quali ogni impresa è immersa. Perché, in fondo, l’innovazione non è tale se non è anche – e soprattutto – trasformazione del senso.
Tre le attività promosse dalla nostra Fondazione – accanto a ricerca, comunicazione e advocacy, necessarie per aumentare la consapevolezza sul tema – anche il contributo alla stesura di norme e regolamenti, come, ad esempio, il recente impegno nella redazione della nuova edizione della UNI PdR 147 “Sostenibilità digitale – Requisiti e indicatori per i processi di innovazione” che, con un approccio semplificato e più omogeneo, rappresenta un valido strumento per sviluppare processi di miglioramento.
In questo contesto va ricordato che le norme di riferimento, i percorsi di conformità e la collaborazione con gli organismi di certificazione accreditati sono, per ogni impresa, i migliori alleati in grado di accelerare i processi di innovazione e sostenibilità.
La misura “Transizione 5.0” è stata indirizzata a premiare le imprese che attraverso tecnologie digitali garantivano il raggiungimento di un determinato risparmio energetico. A prescindere da come tecnicamente la misura è stata gestita, lei ritiene che fosse in linea con i principi della sostenibilità digitale? In alternativa, come vedrebbe una misura orientata a favorire un approccio alla digitalizzazione che contribuisca allo sviluppo di imprese maggiormente sostenibili?
Partiamo da un dato di fatto: l’idea di legare gli incentivi per la digitalizzazione al risparmio energetico rappresenta, almeno in linea di principio, un segnale positivo. Un tentativo di far dialogare transizione digitale e transizione ecologica, laddove troppo spesso sono vissute come mondi paralleli. Tuttavia, il problema non è tanto ciò che si è fatto, quanto ciò che si è scelto di non vedere.
La misura, così com’è stata concepita, soffre di un approccio riduzionista. Premia il risparmio energetico – e questo va bene – ma ignora o sottovaluta dimensioni altrettanto cruciali della sostenibilità digitale: l’inclusione sociale, la trasparenza nella gestione dei dati, la resilienza cibernetica, l’equità economica nei territori. Come se sostenibilità volesse dire solo “ambiente”, dimenticando che si regge su tre pilastri: ambientale, sociale, economico.
A ciò si aggiunge una logica prevalentemente strumentale: molte imprese hanno colto l’occasione non per trasformarsi, ma per accedere a risorse. Non si può biasimarle: se l’incentivo è solo economico, il comportamento razionale sarà adeguarsi all’incentivo. Ma è proprio per questo che una misura pubblica dovrebbe essere anche – e soprattutto – educativa, orientativa, culturale.

Ecco il vero punto critico: la mancanza di accompagnamento culturale. Si è parlato di tecnologie, ma poco di visione. Di macchine, ma non di persone. Nessun investimento significativo in formazione sistemica, nessun percorso di consapevolezza. E così il rischio è che le imprese digitalizzino processi vecchi, anziché ripensare modelli nuovi. In altri termini: che il digitale venga usato per fare più velocemente ciò che già facevano, invece che per fare meglio – e in modo più sostenibile – ciò che dovrebbero fare.
Come uscire da questa impasse? Serve una misura diversa. O meglio, serve un impianto concettuale differente. Un modello che si articoli attorno a quattro assi:
- Multidimensionalità degli impatti: Sostenere solo chi risparmia energia è miope. Bisogna premiare chi genera valore ambientale, ma anche sociale (lavoro dignitoso, inclusione, accessibilità) ed economico (rafforzamento delle filiere locali, economia circolare, redistribuzione del valore).
- Indicatori integrati: Serve affiancare agli indicatori quantitativi (kWh risparmiati) quelli qualitativi (qualità del lavoro, etica dei dati, impatto sui territori). Perché ciò che conta davvero, spesso, non si misura in kilowatt.
- Formazione strutturale: Ogni incentivo dovrebbe prevedere percorsi obbligatori di formazione alla sostenibilità digitale. Non come “onere”, ma come condizione per attivare un cambiamento consapevole. Perché un’impresa formata è un’impresa che sceglie, non che rincorre.
- Sperimentazione e co-progettazione: Infine, bisogna uscire dalla logica dell’impresa isolata e promuovere reti territoriali in cui aziende, enti locali e università collaborino alla costruzione di soluzioni scalabili. Non solo incentivi, ma infrastrutture di innovazione collaborativa.
“Transizione 5.0” ha rappresentato un primo passo. Ma se vogliamo davvero che la transizione sia tale – e non un maquillage verde di modelli obsoleti – serve molto di più: serve un digitale che non sia solo più efficiente, ma anche più giusto, più umano, più consapevole. In una parola: sostenibile

La Fondazione per la Sostenibilità Digitale ha tra i propri soci e partner sostenitori le principali imprese del Paese, le istituzioni che si occupano di trasformazione digitale, molte università. Come ritenete di portare il vostro manifesto e i vostri principi nelle PMI che rappresentano la maggioranza del tessuto imprenditoriale italiano? In questo impegno, quale può essere il ruolo delle Associazioni imprenditoriali quali Anima Confindustria?
Se vogliamo che la sostenibilità digitale non resti un concetto astratto, buono per le aule universitarie o per i panel delle grandi conferenze, ma diventi davvero un motore di cambiamento per il sistema produttivo italiano, dobbiamo partire da un presupposto tanto semplice quanto radicale: parlare alle PMI non significa semplificare il messaggio, ma renderlo comprensibile senza svilirne la complessità. Tradurlo, senza tradirlo.
Alla Fondazione per la Sostenibilità Digitale siamo perfettamente consapevoli che la trasformazione digitale del nostro Paese passerà, o fallirà, proprio attraverso il coinvolgimento delle piccole e medie imprese. Non si tratta solo di “includerle”: si tratta di riconoscerle come protagoniste, come architrave del tessuto imprenditoriale italiano. Ed è a loro che vogliamo e dobbiamo portare i principi del nostro Manifesto, affinché diventino strumenti di lavoro, leve di sviluppo, occasioni concrete di innovazione sostenibile.
Come farlo? Lavorando lungo tre assi strategici.
Primo: la traduzione operativa.
Non basta avere buoni principi se questi non sono agibili. Per questo stiamo rielaborando il Manifesto in chiave settoriale, adattandolo ai linguaggi, ai bisogni e alle dinamiche di filiera: dalla meccanica al tessile, dall’agroalimentare all’automazione. Ogni settore ha le sue priorità, i suoi margini di miglioramento, le sue barriere culturali. Noi vogliamo parlare con esempi concreti, casi d’uso, strumenti di autovalutazione. Non per abbassare l’asticella, ma per rendere il salto possibile.
Secondo: la costruzione di ecosistemi territoriali.
La sostenibilità digitale non si fa da soli. Si fa insieme. Per questo promuoviamo hub locali – in collaborazione con università, Camere di Commercio, centri di ricerca, enti pubblici – capaci di generare quella “contaminazione positiva” tra imprese già virtuose e realtà in fase di transizione. Luoghi in cui non solo si formano competenze, ma si coltivano relazioni. Dove il digitale diventa non solo tecnologia, ma cultura condivisa.
Terzo: il ruolo delle associazioni imprenditoriali.
È qui che attori come Anima Confindustria possono fare la differenza. Le associazioni non sono semplici intermediari: sono costruttori di fiducia, catalizzatori di comunità. Possono integrare la sostenibilità digitale nei propri percorsi formativi, co-progettare strumenti settoriali per la misurazione degli impatti, facilitare l’accesso a fondi e incentivi strutturati, come quelli del PNRR o di Transizione 5.0. Possono, in sintesi, tradurre la strategia in operatività.
Dunque, non si tratta solo di “portare un messaggio”: si tratta di costruire un’infrastruttura sociale e culturale che renda quel messaggio fertile. Perché la vera sfida, oggi, non è far parlare la grande impresa. È far dialogare la grande impresa con la piccola, l’università con l’officina, il policymaker con chi ogni giorno tiene in piedi la manifattura del Paese.
Ecco perché diciamo che la sostenibilità digitale deve uscire dai convegni ed entrare nei capannoni. Deve abitare i processi, ispirare le strategie, guidare le scelte. Solo così potremo davvero parlare di transizione. Ma soprattutto: solo così potremo dire di essere all’altezza della complessità del nostro tempo.